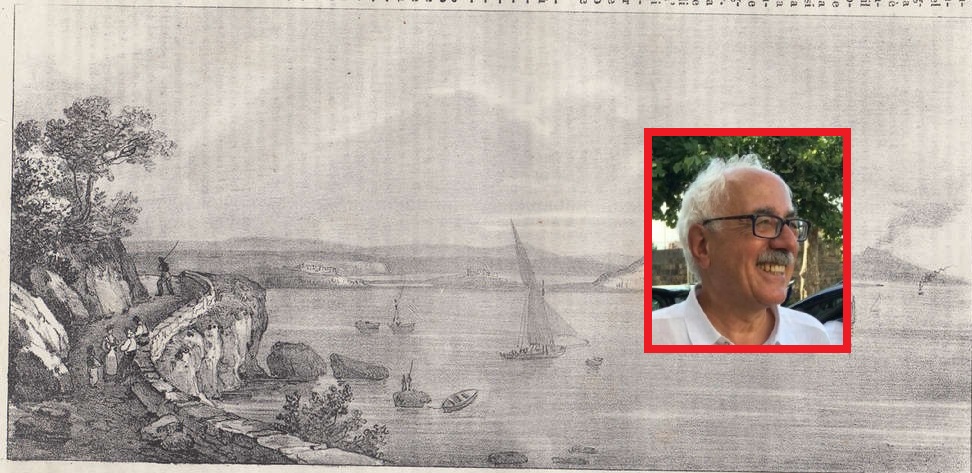Giovanni Romeo – Uno dei più curiosi proverbi procidani, tuttora diffuso nell’isola, riguarda il clero. Il testo (Muónache, priévete e pisce re funno mángeno, véveno e fóttene ‘u munno) collega icasticamente gli ecclesiastici tutti, senza distinzioni, ai pesci di fondo: gli uni e gli altri sono accomunati, oltre che dalla voracità, dalla furbizia con cui soddisfano i propri appetiti. Quando sia nato e chi l’abbia coniato non si sa. È degno di nota, tuttavia, che fino a pochi anni fa anche alcuni sacerdoti locali lo ricordavano bonariamente, senza acredine alcuna.
Da tempo, peraltro, a chi studia senza pregiudizi la storia del clero cattolico nell’Europa medievale e moderna il proverbio or ora ricordato appare fin troppo benevolo. Le stesse dolorose vicende contemporanee che vedono tanti ecclesiastici, anche autorevoli, coinvolti in casi di pedofilia, nel silenzio abituale dei superiori, sono davvero poca cosa rispetto alla routine del Sei-Settecento: alla familiarità di tanti uomini di Chiesa con crimini comuni non di rado brutali i vescovi e le competenti Congregazioni romane garantivano quasi sempre le necessarie coperture.
Dagli eccessi più gravi, però, il clero di Procida sembra per tutta l’età moderna sostanzialmente immune: a suo carico, finora, al di là di atti di prepotenza o di risse di poco conto non sono attestati né fatti di sangue gravi, né casi di pedofilia. Per il resto, invece, il proverbio qui ricordato appare veritiero: venalità, edonismo, abusi sessuali e partecipazione interessata alle battaglie politiche rientrano, in età moderna, nella vita quotidiana di parecchi chierici e sacerdoti isolani.
Due di essi meritano di essere qui ricordati per la sfrontatezza con cui hanno operato. Il primo, don Tommaso Scotto di Minico, riuscì a stupire anche un arcivescovo che si impegnò intensamente per ricondurre un’isola ‘difficile’ a una vita cristiana degna di questo nome, il card. Innico Caracciolo. Fu lui a stigmatizzare, infuriato, un elenco truffaldino di spese stilato da Scotto di Minico, nella sua qualità di cellerario, cioè di amministratore dei beni della Chiesa locale, in funzione del rimborso. Le aveva sostenute nel 1668, a suo dire, il clero isolano, in occasione della visita pastorale dell’arcivescovo, durata tre-quattro giorni.
Erano cifre gonfiate ad arte da quel prete, secondo il cardinale, nell’intento di fare la cresta, ma in modo goffo e ben poco credibile… Alcune delle frasi del prelato meritano di essere ricordate. A proposito del presunto acquisto di una vitella, a caro prezzo, a Varcaturo, annotò: ‘Che vitella? I miei non hebbero altro che carne di capra…”. Quanto poi all’asserita spesa di ben 30 ducati per comprare a Casamicciola due sporte di lazzeruoli bianchi, commentò: “È cosa da dirsi in Turchia, non fra christiani”… Malgrado l’indignazione, non risulta però che il Caracciolo abbia punito don Tommaso, che continuò imperterrito a rastrellare soldi per tutta la vita (ci vorrebbe un’indagine a parte per ricostruirne la venalità).
Quasi un secolo dopo, scenari altrettanto compatibili con il singolare proverbio sono quelli che riguardano la figura di un altro discusso prete isolano. Si chiamava don Antonio Scotto Di Martino ed era un ‘cervello torbido’, secondo il notaio Domenico Florentino, che nel 1751 ne segnalò le malefatte alla Delegazione della Real Giurisdizione, l’organismo statale deputato a tutelare i sudditi dagli abusi degli ecclesiastici.
Divenuto presto ricco e potente, nonostante le umili origini, si mostrò per tutta la vita un uomo spregiudicato e violento, insieme a due fratelli, anch’essi sacerdoti. Legato notoriamente a una donna sposata, disinvolto nel parlare (diceva addirittura che sopra la chierica voleva farsi crescere il ciuffo, “dinotando da christiano divenire maumettano”), si mostrava spesso prepotente e vendicativo. Due episodi avevano particolarmente indignato gli isolani: lo schiaffo a un contadino che aveva rifiutato di vendergli della verdura a prezzo scontato e il tentativo di avvelenare in un’osteria di Monte di Procida dei funzionari pubblici che gli avevano negato un trattamento di favore.
A questi comportamenti sfrontati don Antonio aggiungeva poi l’accanimento e la partigianeria con cui partecipava alla lotta politica locale. Ogni anno, nelle elezioni comunali, si schierava apertamente per una delle due fazioni in lotta, quella capeggiata dalla sua famiglia. Gestire i 5.000 ducati annui del bilancio del Comune era l’obiettivo principale di quell’impegno, cui si dedicava con zelo degno di miglior causa. In funzione del successo elettorale girava in lungo e in largo per l’isola, sia per procacciare consensi ai propri candidati, sia per tessere trame – false querele, soprattutto – capaci di compromettere l’immagine degli avversari.
Di fronte ad accuse così pesanti e circostanziate la Delegazione della Real Giurisdizione preferì evitare interventi decisi. Si limitò a raccomandare al governatore di Procida di invitare don Antonio a non immischiarsi più in quelle questioni e a fare il prete. Tuttavia, anche se non sappiamo più nulla sul suo conto, una cosa è certa. Una delle famiglie più legate alla fazione da lui capeggiata, quella dei Lubrano di Vavaria, riuscì a ottenere nel 1771 per un suo esponente, don Niccolò, il prestigioso incarico di curato di Procida. Ma il carattere difficile e la forte passione per la politica lo condussero nel 1799 sul patibolo, come sostenitore della Repubblica napoletana.